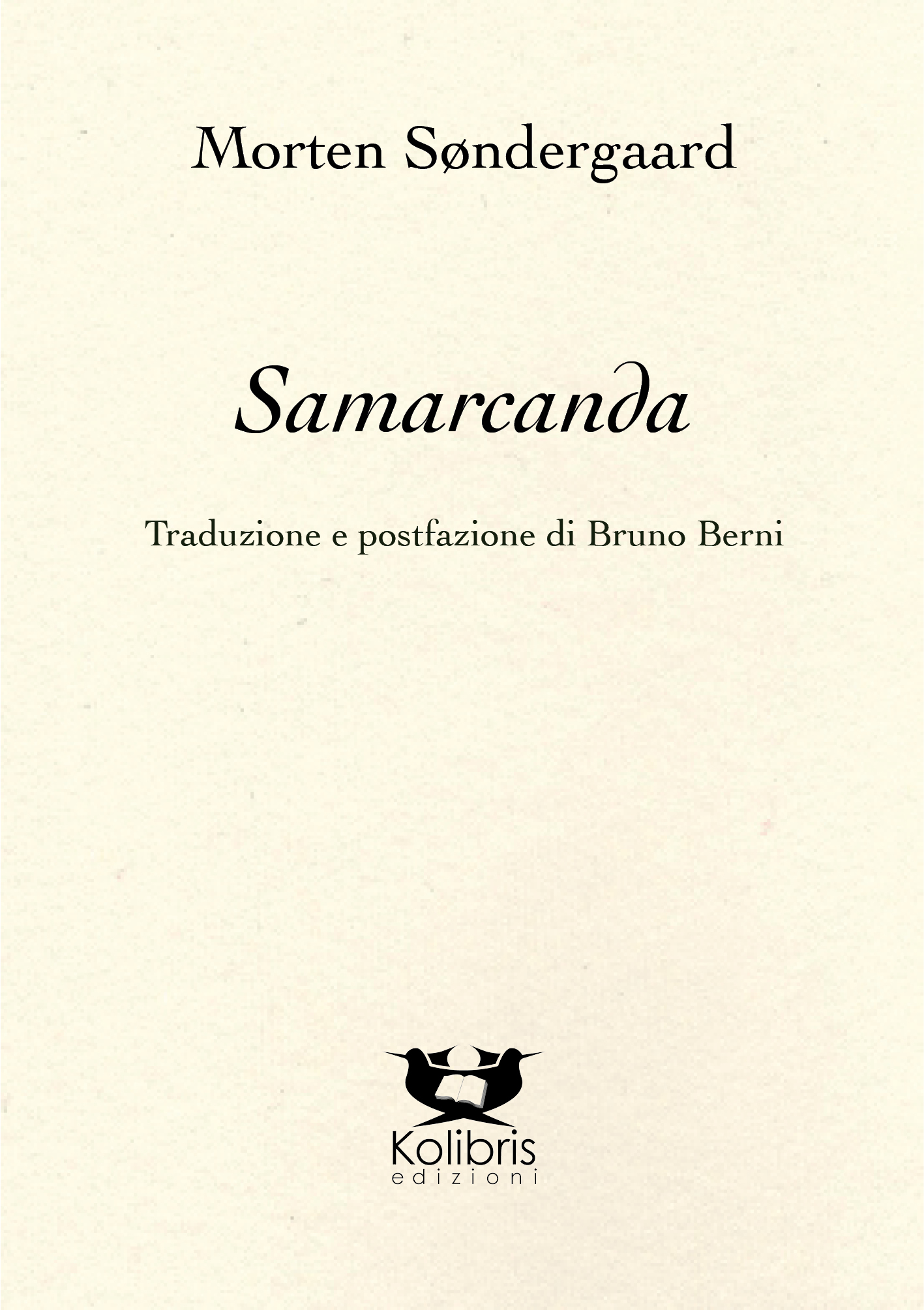Collana Beija-flor – Poesia portoghese
Collana Beija-flor – Poesia portoghese
Golgona Anghel, Sono venuta perché mi pagavano
Traduzione di Chiara De Luca
Postfazione di Stefano Serri
ISBN: 979-12-81236-15-8
pp. 126, € 15
Questo libro è una passeggiata accanitamente attenta, ironica, ma senza allegre risate, senza farsi notare: se resti cosa tra le cose puoi continuare a esplorare, senza dover per forza assumere un io umano, troppo umano. Era il nostro campo di concentramento della felicità, scrive la poetessa.
L’attenzione, quindi, come ultima forma permessa di purezza e redenzione (Ma la poesia, mes chers, non salva, non brilla, caccia e basta), una purezza ben nascosta tra vodka, trucco e appuntamenti occasionali, una purezza obliqua che rinuncia all’enunciato diretto, fa molti e chiari cerchi in aria, sembra che si allontani, feconda più volte e a piccoli tocchi la parola da dire, prima di lasciarla andare e passare al fiore successivo.
A volte, perdere tempo (per vedere chi passa, elencare incertezze, ammucchiare minuzie) è l’unico modo di non perdersi. La poetessa lo perde a suo agio, il tempo, ha ancora troppo mondo da vedere, inutilmente forse, ma è un mondo che le/ci chiede di essere visto; è una totalità di esperienze mancanti, un tutto incontenibile e incontentabile, un pan di noia e speranza che diventa presto quel gigante del minimalismo, / il panico. Passeggia anche ansia, in questi versi, ma non troviamo nessuna estrema disperazione: la morte non è altro che fare due passi nella parte più buia della foresta.
Agogicamente, Golgona Anghel mi sembra un andante – non è in sé un’offesa o un complimento, in un panorama di istantanei e prestissimi rondò. Un andante che, ogni tanto, soprattutto parlando d’amore, si fa un po’ furioso, per poi ritornare al tempo primo. Ma è sempre cantabile, questo andante con moto, lirico anche quando elenca personaggi storici, merci, luoghi pubblici o vissuti consumistici.
La poesia di Golgona Anghel è un collage con molto spazio bianco attorno alle figure ritagliate e poi incollate, un collage anch’esso sempre cantabile, dove quel che più risalta è quel che manca – e non è forse un caso che siano intitolate Senza le tre sezioni del volume.
Dalla postfazione di Stefano Serri
Finita la seconda guerra mondiale,
ebbe la sagacia di venire a farmi visita,
nel momento in cui la terra
non aveva ancora fatto in tempo a ingoiare i morti
e la rovina era servita come piatto forte ai turisti.
Cercavo di ripulire le mie incertezze e
usavo per stenditoio l’elica di un aereo inglese.
«Dovrà immergere i ricordi tutti nel passato».
«Il Patto di Varsavia lo ricompenserà
per tutte le perdite
e gli eventuali danni collaterali».
«È complicato, certamente;
sismi lucenti ancora fulminano i suoi silenzi».
Nella ripetizione del programma, qui,
c’era spazio per la piccola pubblicità.
Negli iati, un uccello.
Un’ombra mi faceva vacillare le idee,
ma io appoggiavo i giorni futuri al mio passo sicuro,
all’evidenza di quell’alba di gennaio.
Misuravo con la mia altezza tutte le porte d’uscita.
Contavo i fari che andavano in senso opposto.
Leggevo a voce alta i cartelli che indicavano
la strada per andare fuori, lontano,
il nome delle località,
taverne e negozi di alimentari,
pollo arrosto a 100 m,
abbiamo carbone, proiettili persi e ritrovati,
tabacco, stivali in pelle di varie misure, ecc.
Avevo, certamente, il ritorno programmato,
il bagaglio appoggiato all’alba
e le dita a sparare
senza sosta. Contro il destino,
contro il personaggio principale.
L’ultima lettera ricevuta a mio nome
contemplava tutto questo.
Mi assegnavano perfino una medaglia
per aver compreso che,
anche se mi stanco di più,
essere sepolto in piedi
occupa meno spazio.
***
Il suo andare a passeggio,
esitante come un principiante qualunque,
l’epicentro delle sue menzogne,
il campo magnetico del suo piacere,
il polo nord del suo sesso,
quella sua malinconia di magnolia
incisa sull’orizzonte di tante Hiroshima
sarebbero un disastro a Mishima.
Ma quel dente da pipistrello
a dimostrare la corazza della mia pazienza, quella
mania di svegliarci ogni giorno,
di non avere nulla e possedere tutto,
questo è ciò che ci unisce per l’eternità.
Oltre ai complessi freudiani,
fuori dalle restrizioni genetiche,
sotto qualunque sospetto
sistemato in fretta nei libri sul comodino.
Quando mi chiedono di noi
non esito a motivare la mia risposta
invocando le muse greche e i loro curatori,
fornendo esempi pertinenti
come questo:
ibamus obscuri sola sub nocte.
Le migliaia di monadi della mia storia psichica
girano ciclicamente attorno alla sua frangia,
passano ore
a contemplare il suo pareo
nell’ondeggiare lieve dei campi.
Quando non ci sono raccolti,
accendo la ventola e la gonna ci svolazza dentro.
Ci sarà senz’altro un tempo in cui
gli annali di google renderanno disponibili online
i file segreti del nostro destino.
Qualcuno dirà, perciò,
con la voce distorta dalla censura,
che mi abbandonava infinite volte
con l’esagerazione delle iperboli,
che tornava poi
con il rimorso tacito dei puntini di sospensione,
fino a quando?
che notte dopo notte mi forniva squisiti
incubi, fiori di plastica e pasticche Trident,
finché un giorno,
prese il tempo che ci restava insieme
e andò a fare due passi nella parte più buia della foresta.
***
Sono venuta perché mi pagavano,
e volevo comprarmi a rate il futuro.
Sono venuta perché mi parlavano di cogliere ciliegie
o di armi di distruzione di massa.
Ma ho incontrato solo cuculi e pettegolezzi da fiera,
mitragliatrici di plastica, conigli pasquali e bracciali di latta.
A bordo, qualcuno parlò di giustizia
(no, non era Marx).
A bordo, parlavano anche di libertà.
Tanto più moriamo,
quanta più libertà abbiamo di ammazzare.
Ammazzavo perché eri vicino,
perché gli altri restavano nell’angolo del supermercato
a parlare, a dibattere la questione.
Con queste mani alzai la polvere
con cui ora copro i nostri corpi.
Con queste gambe risalii dieci piani
per poterti così guardare in faccia.
Qualcuno osa ancora parlare di posterità?
Io sola penso a come tornare a casa;
e che bello mi resta la speranza
mentre presento in diretta
l’autopsia della mia gloria.